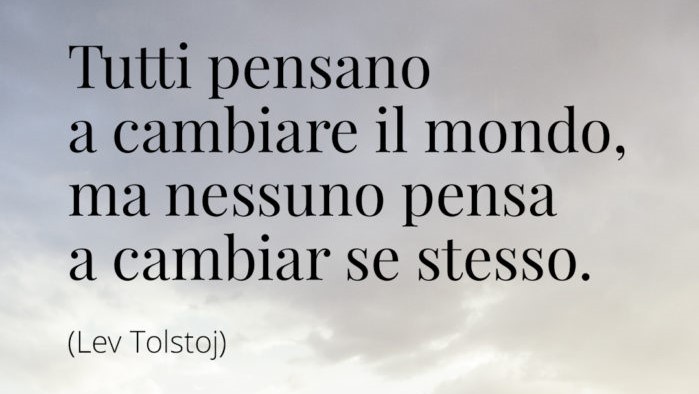Serve oggi una nuova narrazione, che faccia riferimento ad un’idea di Paese non più divisiva ma unitaria sulla quale fondare le politiche per la crescita. L’errore sinora largamente fatto è stato quello di una narrazione Nord/Sud come due entità distinte con problemi diversi e, perciò, alla ricerca di soluzioni distinte.
La rappresentazione distorsiva racconta invece di una demarcazione netta tra Nord e Sud. Un Nord che produce ed un Sud che consuma.Un Nord che va fatto crescere per competere ed un Sud che invece va assistito.
Il gap occupazionale Nord-Sud, solo nel 2018, è stato di quasi 3 milioni di persone e complessivamente il divario tra le due aree continua ad allargarsi. E i costi di questa demarcazione la pagano in misura maggiore le fasce più deboli, donne e giovani del sud.
Il riequilibrio tra nord e sud richiede allora politiche economiche e sociali che promuovano competitività e coesione, e che però partano da una lettura corretta della situazione, non distorta nelle premesse e quindi nelle conclusioni.
Partiamo da alcuni esemplari dati. Le regioni del Sud Italia hanno il più basso tasso di occupazione d’Europa! Nel 2018 gli occupati al Sud tornati sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle regioni del Sud. Rispetto a una media Ue del 73,1% (dati Eurostat 2018), al Sud solo il 45% delle persone tra i 20 e i 64 anni ha un lavoro. In Sicilia il 44,1%. Lavoro precario e a tempo compresi.
Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. La disoccupazione giovanile, invece, raggiunge il tasso record del 51,9%, il 53,6% in Sicilia. E tocca punte massime al crescere del livello di istruzione. In pratica, un giovane meridionale su 2 non lavora, e l’emergenza lavoro per i giovani Sud non accenna a ridursi determinando, insieme al ridotto tasso di natalità, lo spopolamento delle aree del sud.
L’OCSE ha rimesso l’Italia al primo posto per emigrazione. Uno dei punti di maggiore fragilità del Sud sono i giovani, costretti ad abbandonare il Sud. Falcidiati dal calo delle nascite degli ultimi anni, sono sempre meno e meno presenti sul mercato del lavoro e hanno peggiori condizioni lavorative, maggiore precarietà, più bassi salari.
Ed è però profondamente errata la narrazione che si fa dei giovani del sud rassegnati a rimanere fuori dal mondo del lavoro.
Le statistiche pubblicate da UnionCamere dicono infatti altro. Le nuove imprese under35 anni al Sud sono il 40,7%, al Nord il 39,6%. Al sud malgrado tutto, e malgrado i tassi di emigrazione e neet c’è voglia di intrapresa giovanile. Ma non ci sono le condizioni perché queste imprese da startup facciano il salto in aziende mature. Tra il 2002 e il 2017 gli emigrati dal Sud sono stati più di 2 milioni, di cui la metà sotto i 35 anni. Al netto dei rientri, il Sud ha perso 852mila persone).
Le regioni del Sud Italia sono le ultime in Europa per tasso di attività e tasso di occupazione femminile e detengono il record per NEET.
La questione anagrafica e di genere diventa perciò paradigmatica per cogliere le crescenti difficoltà del Sud. E sono dati, questi, che entrano tutti nel computo della quantità di risorse Ue assegnate all’Italia.
Un Sud indietro nei parametri ma che non sa usare i fondi UE conviene quindi al Nord.
I gap del sud cioè mantengono alta la quota di risorse UE che l’UE stanzia all’Italia mentre non altrettanto alta è la quota di risorse che va a beneficiari del Sud.
I fondi europei vengono assegnati all’Italia in misura direttamente proporzionale agli indici di sottosviluppo del Sud, e che gli stessi sono destinati per l’85% al Sud, al fine di ridurre proprio le differenze di velocità, ma vengono invece utilizzati invece per il 73% al Centro-Nord.
Nel Sud l’impoverimento della società insieme al progressivo peggioramento nell’offerta dei servizi pubblici essenziali (scuola, sanità e servizi sociali) e la gravissima carenza infrastrutturale (deterrente per sviluppare impresa ed attrarre investimenti) hanno avuto negli ultimi anni come prevalente proposta politica tutte le forme di ammortizzatori sociali e risorse per finanziare opere senza progettazione e, ancor peggio, senza risorse e mezzi per la progettazione.
Nessun concreto strumento per la crescita endogena e la connessione infrastrutturale, nessun reale strumento per la crescita.
Ciò ha confinato il sud a restare sud ed aumentare il suo divario: un sud sempre più dipendente dalla singola proposta politica di assistenza e non invece impegnato in puntuali politiche mirate alla crescita (credito di imposta al sud, fiscalità di vantaggio, competence center, …).
E’ al Sud uno solo (a Napoli) dei 7 competence center, che sono il luogo per eccellenza di innovazione, attrazione investimenti e lavoro per i giovani.
La contrapposizione tra un Nord produttivo e connesso con il mondo (ma tartassato da iniquità fiscali dovute alla zavorra Sud) ed un Sud inerme ed assistito è stata la scusa per delegare ai fondi strutturali la responsabilità del mancato sviluppo del sud e orientare invece le risorse nazionali ad accrescere la competitività del nord.
Non ci si può aspettare dai soli fondi strutturali una ripresa del processo di sviluppo del Sud. Nonostante ingenti stanziamenti, il Sud cresce sempre meno: meno del passato, meno delle regioni del Centro Nord, meno delle altre regioni europee in ritardo di sviluppo.
Solo negli ultimi dieci anni la spesa pubblica è stata ridotta al Sud dell’8,6% mentre è stata accresciuta dell’1,4% al Centro-Nord; e ogni anno sono stati sottratti al Sud 61,5 miliardi di euro per essere trasferiti al Nord.
Per favorire strutturali e duraturi processi di crescita del Mezzogiorno è quanto mai doveroso non relegare il Sud ad essere la zavorra dello sviluppo del sistema Paese, ma motore di crescita del Paese attraverso una seria riflessione sul valore e ruolo dei giovani in questa crescita. I giovani che, in assenza di risposte, stiamo lasciando andare via.
Serve superare i gap in termini di infrastrutture, sistemi di logistica, politiche integrative di welfare, strumenti di incentivazione alla crescita e all’auto-impresa, politiche per creare vantaggio fiscale ad investire e ad assumere al sud, politiche per valorizzare le competenze locali per trattenere i giovani, misure per arginare lo spopolamento del Sud, misure per promuovere innovazione e la transizione digitale.
Al sud non servono stampelle, surrogati del lavoro, misure di assistenza, ammortizzatori che servono solo a mettere ancora in pausa lo sviluppo del sud aumentando il gap con il nord. Al sud servono i treni ad alta velocità e le autostrade a 4 corsie, le piattaforme logistiche, i competence center .
E men che mai serve quella insulsa generosa pacca sulle spalle quando ci dicono che tanto potremmo vivere di turismo; non di lavoro, ma di turismo. Un sud spopolato dai suoi cittadini e segregato per quantità e qualità lavorativa come potrebbe mai attrarre investimenti turistici che producano economia e occupazione per il territorio? Come può mai organizzarsi per un turismo di qualità che raggiunga i numeri delle canarie ?
Il costo che paga il Sud in termini di emigrazione dei nostri giovani non è solo in termini di sottrazione di capitale umano e di generatori di futuro ma è anche un costo diretto. Perché resta in carico al sud il costo sostenuto per crescere nelle famiglie e formare questi giovani.
Il Sud è parte integrante del sistema produttivo e sociale del Paese nelle sue aree più vitali e deve ripartire dalle sue “risorse endogene”, non da strumenti di mera assistenza o dall’abbaglio dell’attrazione di investimenti che è poi la forma moderna del colonialismo (di mera convenienza solo per l’investitore che quando raggiunge il suo break-even sbaracca).
I fondi strutturali sostituiscono ormai normalmente la mancata spesa ordinaria e con una percentuale crescente negli ultimi anni. La dimensione dei fondi strutturali, pur rilevante, è però pari a meno della metà del totale della spesa in conto capitale nel Mezzogiorno, e meno del 5% del totale della spesa pubblica.
Appare molto difficile che un intervento di tale entità possa essere di per sé sufficiente a mutare le sorti di un territorio così ampio come il Mezzogiorno, senza una profonda azione di potenziamento dell’intervento nazionale di “sviluppo” (infrastrutture, ricerca, istruzione, politiche economiche sociali), e di riqualificazione della spesa ordinaria.
Ci siamo concentrati sui fondi europei (che peraltro non finanziano più infrastrutture dal ciclo 14-20) e ci siamo distratti sul fondo sviluppo e coesione (che complessivamente muove più risorse la maggior parte della quali destinate alle infrastrutture).
Dobbiamo pretendere che sia rispettata la clausola della legge mezzogiorno che prevede di stanziare al Sud il 34% della spesa in conto capitale.
Per colmare il gap tra Nord e Sud serve infrastrutturare il Sud: richiamando alle loro responsabilità le società pubbliche nazionali (Eni, Ferrovie, Cassa Depositi e Prestiti) perche nei loro piani prevedano una quota proporzionale alla popolazione di investimenti al sud (e non solo per manutenzioni, ma anche per nuove opere necessarie al recupero del gap infrastrutturale).
Chiediamo poi politiche puntuali sui Servizi essenziali: che sono il campo in cui si distinguono i cittadini di serie A dai cittadini di serie B, e sempre più i cittadini del Nord da quelli del Sud.
Istruzione, Sanità, Servizi di Cura. Dove è sempre più evidente la faglia tra nord e sud. E che sono poi i temi alla base dell’emigrazione dei nostri giovani e causa dello spopolamento del Sud.
Scuola, Sanità, Servizi di cura : tutti ambiti dove – si faccia caso – è prevalente il potenziale di forza lavoro femminile. Tutti settori dove è prevalente il lavoro precario, ed in molti casi il lavoro sottoretribuito, se non in nero.
Tutti settori da cui si deve ripartire il confronto.